
La guerra in Ucraina è figlia di armistizi mancati e di linee rosse che s’intersecano pericolosamente.
Gli accordi di Yalta, al termine del secondo conflitto mondiale, certificarono il suicidio dell’Europa: dopo una trentennale guerra civile (1914 – 1945), da padrona del mondo si ritrovò oggetto di spartizione delle due nuove superpotenze planetarie, gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica. A Yalta furono tracciati i confini dei due imperi, ovviamente senza tener conto, da ambo le parti, del principio di autodeterminazione dei popoli, ma seguendo esclusivamente la logica delle sfere d’influenza. Ove erano necessari degli “stati cuscinetto”, fu imposta la neutralità di comune accordo tra le due superpotenze – Finlandia e Austria, per esempio – senza tener conto della volontà dei popoli coinvolti, sacrificata al bene supremo della sicurezza mondiale.
La spartizione di Yalta ebbe valore fino al termine della “guerra fredda”, determinata dall’implosione dell’impero russo. A quel punto la definizione di un nuovo accordo sarebbe stata necessaria per tracciare le nuove sfere d’influenza delle due superpotenze, la vincente e la perdente. D’altronde, a meno del totale annientamento del nemico – come fu nel caso della Germania nazista – al termine di una guerra il nuovo equilibrio di potere è sempre definito da un armistizio. A fortiori quando la parte soccombente ha mantenuto intatto il suo potenziale militare, rappresentato in questo caso da un arsenale nucleare di potenza comparabile a quella dei vincitori.
Tuttavia al termine della “guerra fredda” non ci fu nessun armistizio.
Gli americani non lo ritennero necessario. Evidentemente nemmeno i russi, che non lo chiesero. Sembrerebbe che tra Reagan e Gorbaciov ci fu un Gentlemen’s Agreement, con il quale gli Stati Uniti s’impegnarono a non spostare verso est l’estensione del loro impero ai danni di quello russo. Scrivo “sembrerebbe”, perché non è rimasto nulla di scritto, per cui possiamo solo affidarci ai racconti dei protagonisti.
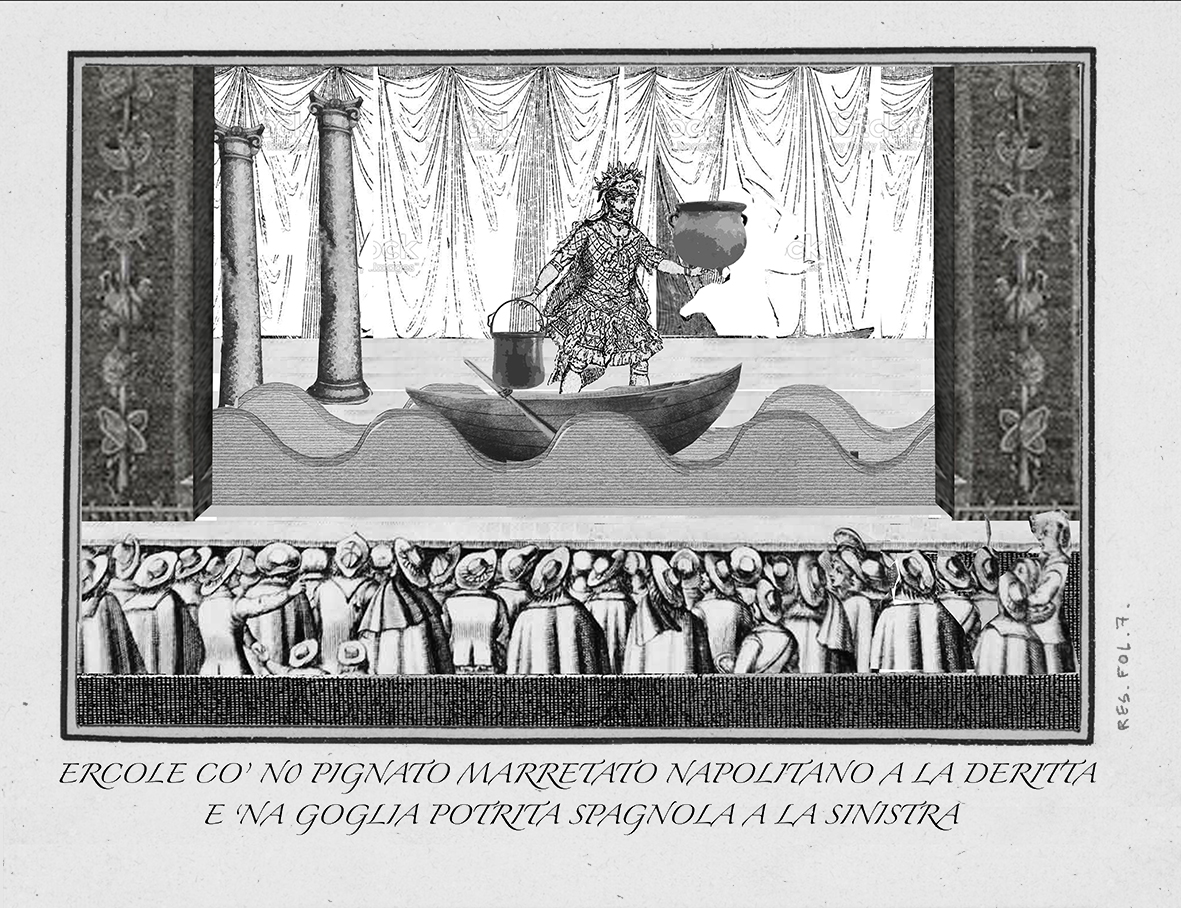
Tuttavia, se ci fu, si trattò di un accordo irrealistico, poiché a fronte di un cambiamento sostanziale dei rapporti di forza tra due contendenti, le loro sfere d’influenza non possono restare immutate. Inoltre le nazioni sottomesse da un impero in ascesa, non appena esso mostri di non avere più la forza per mantenere le posizioni, si muovono immediatamente per riempire il vuoto di potere, recuperare la sovranità perduta e scagliarsi contro i vecchi dominatori con spirito fortemente revanscista. Il confine tra i due imperi, dunque, si spostò rapidamente verso est con l’adesione alla NATO di tutto il blocco dei paesi dell’ex Patto di Varsavia. Spostamento rapido, ma non indolore, dato che generò una guerra cruenta nei Balcani, dove la Serbia, tradizionale avamposto russo nel cuore dell’Europa, ha cercato di opporre resistenza all’ineluttabilità del suo destino sancito dal crollo del muro di Berlino.
Dall’Età Antica all’Età Contemporanea, ogni impero ha sempre definito la propria “linea rossa”, il primo perimetro di difesa da tenere a qualsiasi costo, per impedire l’invasione di un’entità nemica. Definizione non per decisione politica soggettiva, ma per imposizione da parte di oggettivi imperativi difensivi, giacché la presenza di forze ostili al di qua del perimetro, comporta un concreto pericolo esistenziale.
Nella consuetudine dei rapporti diretti tra apparati russi e americani – stabiliti durante la “guerra fredda” per comprimere al minimo il rischio di conflitto nucleare – i primi comunicarono ai secondi la linea rossa da non oltrepassare all’inizio del secolo. Più precisamente nel 2004, l’anno di svolta nei rapporti tra i due imperi, poiché per la prima volta quello americano si spingeva fin dentro i vecchi confini dell’ex-Unione Sovietica, inglobando nella NATO le tre Repubbliche Baltiche.
Non solo, nel novembre del 2003, la “Rivoluzione delle rose” in Georgia aveva fatto cadere il governo filo-russo di Shevardnadze a Tbilisi, con l’insediamento del filo-americano Saakashvili nel gennaio del 2004. Infine – l’evento notevolmente più importante dei tre per le relazioni russo-americane – a novembre dello stesso anno, con la “protesta arancione” – passata alla storia come la “prima rivoluzione ucraina” – e il ribaltamento del risultato elettorale, grazie all’intervento decisivo della Corte Suprema, a Kiev s’insediava il governo del filo-americano Yushenko, estromettendo il filo-russo Yanukovic.
La reazione degli apparati di Mosca fu ferma e decisa: i vecchi confini dell’ex-URSS dovevano essere considerati dagli americani come la prima linea di difesa russa assolutamente invalicabile e l’Ucraina e la Georgia ne erano al di qua.
Quattro anni più tardi, gli americani la testarono in Georgia. Riconfermato a Tbilisi per un secondo mandato, Saakashvili – espressione diretta del Dipartimento di Stato americano – dopo aver chiesto ufficialmente l’adesione all’UE e l’entrata nella NATO, nell’agosto del 2008, decise di regolare il decennale contraddittorio con l’Ossezia del Sud, attaccandola militarmente, per riportarla sotto la sovranità georgiana. La reazione militare russa non si fece attendere e in soli cinque giorni il conflitto armato terminò con la conferma dell’indipendenza della piccola repubblica caucasica.
Nel febbraio del 2010 il filo-russo Yanukovic riconquistò la presidenza dell’Ucraina, ma la sua rielezione per un secondo mandato nel febbraio del 2014 fu contestata dalle ormai celebri proteste di Euromaidan. Il contestuale colpo di Stato, organizzato dalle intelligence americana e inglese, riportò di nuovo Kiev nella sfera d’influenza statunitense, con l’elezione di Poroshenko alla presidenza nel maggio successivo.
Anche in Ucraina la reazione russa non si è fatta attendere, come ben sappiamo, con il colpo di mano in Crimea e il sostegno politico, militare ed economico ai separatisti del Donbass. Un’aggressione ai danni dell’ex “provincia” passata nel campo nemico, che poi si è concretizzata otto anni più tardi con una vera e propria invasione militare, come ci testimonia l’attualità dal 24 febbraio scorso.
Capire cosa abbia fatto precipitare gli eventi a otto anni di distanza dal colpo di Stato a regia anglo-americana che ha, de facto, sottratto all’impero russo la sua “provincia” strategicamente e culturalmente più importante, mi pare poco rilevante. Molto più cruciale credo sia analizzare i fondamentali geopolitici che hanno portato americani e russi al punto più basso delle loro relazioni e il mondo mai così vicino al rischio di conflitto nucleare.
I russi si percepiscono come una realtà imperiale e lo sono effettivamente da un millennio. Tuttavia è una percezione influenzata decisivamente dalla sindrome di accerchiamento con cui convivono fin dalla formazione del loro impero. Ciò perché per costruirlo, consolidarlo e mantenerlo, hanno dovuto combattere nei secoli con le popolazioni più aggressive e bellicose del pianeta, quelle che abitano il suo continente più contendibile: l’Eurasia. Mongoli, tartari, turchi, polacchi, francesi, giapponesi, tedeschi, solo per citarne alcuni. Allo stesso tempo i russi convivono con il trauma delle invasioni da occidente, dove non beneficiano di nessuna protezione derivante da barriere naturali, quali catene montuose o grandi superfici idriche. Solo l’immensa pianura sarmatica, che dall’Europa spalanca le porte a qualsiasi piano di aggressione. Le più recenti invasioni, quella dei francesi nell’’800 e quella dei tedeschi nel ‘900, sono state anche le più traumatiche, per l’altissimo prezzo umano ed economico che i russi hanno dovuto pagare per respingerle.
La proiezione imperiale, la sindrome da accerchiamento, l’inesistenza di barriere naturali protettive hanno plasmato nei secoli l’insicurezza, l’aggressività e un’alta considerazione di sé del popolo russo.
L’Ucraina è la “provincia” di gran lunga più importante per Mosca, non solo per ragioni culturali – russi, bielorussi e ucraini sono le tre popolazioni discendenti dai proto-russi e costituiscono il canone dominante culturale ed etnico-religioso (slavo-russo e cristiano ortodosso) del multietnico e pluriconfessionale impero più esteso del mondo – ed economiche – Ucraina granaio d’Europa, oltre che grande produttrice di acciaio ed energia nucleare – ma soprattutto perché strategica per l’esistenza stessa della Russia. Basti pensare che per il fallimento delle ultime due invasioni da occidente, decisivo fu l’obbligo per le truppe francesi e tedesche di attraversare tutta l’Ucraina, prima di poter combattere, fiaccate dal freddo e dalla mancanza di viveri, contro l’esercito russo, che si era opportunamente ritirato.
Se alla luce di tutto di ciò ci risulta più facile capire perché gli apparati di Mosca abbiano tracciato una linea rossa che deve assolutamente includere l’Ucraina, perché anche per Washington, Kiev sembra assumere una tale importanza strategica da portare il pianeta così vicino all’abisso di un conflitto nucleare?
Le linee rosse definite oggettivamente dagli imperativi difensivi non sono fisse, ma variano nel tempo, secondo lo stadio evolutivo della parabola imperiale.
Se la superpotenza russa si trova in piena decadenza e quindi traccia il suo primo perimetro difensivo geograficamente vicino al cuore, al contrario gli Stati Uniti sono nella fase ascendente e ciò fa spostare la loro linea rossa su meridiani a migliaia di chilometri di distanza dal centro.
Gli apparati di Washington devono mantenere e consolidare il più grande e potente impero, che la storia dell’umanità abbia mai concepito. Un compito immane, per assolvere il quale, si confrontano di continuo e nervosamente con la parabola dell’Antica Roma, di cui si considerano unici degni eredi. La necessità di conservare un domino, de facto incontrastato, sull’intero pianeta, li obbliga a prevedere con largo anticipo ogni evento suscettibile di costituire un futuro pericolo esistenziale, seppur in fase embrionale. Ciò li porta necessariamente a spostare la loro linea rossa sempre più lontano dal centro.
I tedeschi sono il popolo più temuto dagli americani. Li considerano l’unica nazione realmente in grado di sottrargli la supremazia mondiale. Non è qui la sede per indagare i motivi, reali o percepiti, di tale paura recondita, ma è un fatto che da quando gli Stati Uniti si sono proiettati in una dimensione imperiale – inizio del ventesimo secolo – la Germania è diventata la loro ossessione strategica. Hanno combattuto due guerre mondiali per impedire che i tedeschi dominassero l’Europa. Hanno ingaggiato una “guerra fredda” con la Russia, sicuramente per impedire che essa conquistasse il Vecchio Continente, ma anche (o soprattutto?) per tenere sotto controllo congiuntamente la Germania.
Da quando l’impero russo non è più comunista, per gli apparati americani si ripresenta l’imperativo strategico di evitare la naturale convergenza geopolitica tra due collettività quasi perfettamente complementari: quella tedesca e quella russa. Un’unione per alleanza – o per sottomissione – tra le grandi capacità e la rigorosa disciplina sociale dei tedeschi e l’abbondanza di materie prime e di manodopera dei russi, nella percezione degli americani, decreterebbe la fine della loro supremazia e, di conseguenza, del loro impero.
Evitare ab initio qualsiasi seria convergenza tra Russia e Germania è dunque questione di vita o di morte per Washington. Ora che non possono più sfruttare la comoda ed efficace propaganda anti-comunista, gli americani devono trovare altri strumenti per far recitare agli ex-sovietici la parte dei “cattivi” nella loro nuova narrazione. Ruolo che, peraltro, con l’insicurezza, la sindrome da accerchiamento e l’aggressività loro congenite, i russi sembrano svolgere alla perfezione.
L’aggressione all’Ucraina e una guerra di lunga durata sono indubbiamente due eventi di grande efficacia per rappresentare l’”Orso russo” come il Male agli occhi dei tedeschi e quindi per stroncare sul nascere qualsiasi convergenza geopolitica tra Mosca e Berlino. Rappresentazione peraltro fortemente agevolata dalle dimensioni opposte in cui vivono le due collettività.
I russi sono profondamente storici, ben disposti al sacrificio umano ed economico per la glorificazione del mito, la ricerca della potenza, la grandezza dell’impero. Per essi la guerra è parte ineluttabile del destino dell’umanità, condizione qualificante della sua Storia.
I tedeschi invece, dalla disfatta del Terzo Reich, vivono nel più marcato post-storicismo, caratterizzato da profondo economicismo e repulsione assoluta della guerra come strumento di controversia.
CONCLUSIONE
Il post-storicismo caratterizza, seppur con diversi gradi d’intensità, tutte le nazioni dell’Europa occidentale. È una condizione imposta dalla potenza egemone americana per controllare agevolmente le “province” più preziose del suo impero. In ciò ovviamente facilitata dalla voglia di pace delle popolazioni europee dopo i due devastanti conflitti del secolo scorso.
I tedeschi la vivono con la maggiore intensità, proprio perché sono la nazione più temuta dagli americani. Noi italiani, con un grado inferiore, ma maggiormente rispetto a francesi e inglesi. Per vari motivi, tra cui il più importante è il nostro status di nazione sconfitta, insieme alla Germania.
La condizione post-storica fa presa soprattutto sulle élites intellettuali di una collettività, in particolare su quelle più progressiste e riformiste, come dimostra il titolo della rubrica, per cui ho scritto il mio contributo.
SEGNALIAMO












